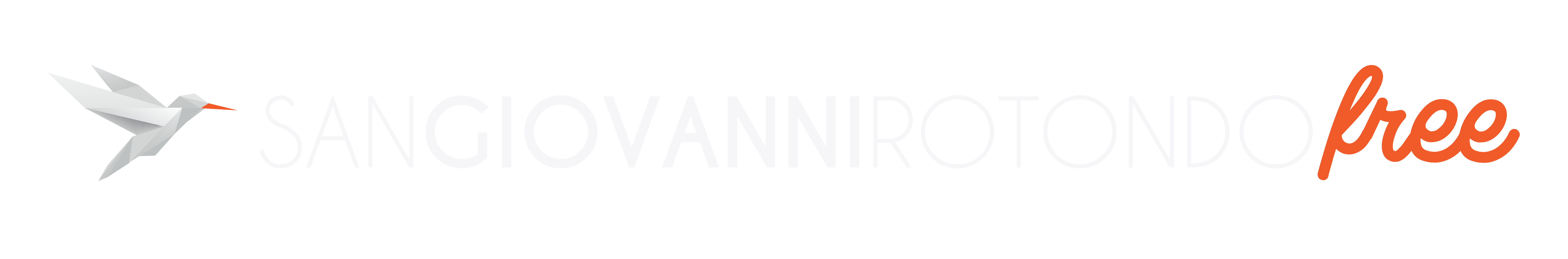La festa cristiana di San Giuseppe, sposo di Maria e padre di Gesù, ha origini antichissime. Prima di essere collegata alla figura Cristiana di san Giuseppe, affondava le proprie radici nel paganesimo e nell’astronomia: infatti, il 19 marzo, è il giorno vigiliare dell’equinozio di primavera, periodo in cui, si svolgevano gli antichi riti di propiziazione e fertilità, i baccanali.
La festa cattolica ha origine poco documentata nella chiesa orientale e viene celebrata in Occidente nell’undicesimo secolo, con la data fissata proprio al 19 marzo. Pio IX lo dichiarò patrono della Chiesa universale nel 1870 e papa Francesco ha cominciato il suo ministero petrino proprio nel giorno a lui dedicato .
Alla sua figura di patrono e protettore dei papà, dei falegnami e degli artigiani viene associata anche quella di custode dei poveri e dei derelitti e, negli ultimi periodi, caso un po’ particolare, il cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e biblista di fama mondiale, in maniera curiosa quanto provocatoria lo ha definito il santo delle partite IVA.
Al fatto che la sua festa cada a pochi giorni dall’inizio astronomico della primavera è dovuta la tradizione dei cosiddetti falò che, anche nella nostra città, fanno parte di un patrimonio culturale, salvaguardato da pochi ma rimpianto da molti: le fanoje.
Un rito purificatore antichissimo per segnare e festeggiare il passaggio dall’inverno alla primavera e che poi, con l’avvento del cristianesimo, ha assunto il significato di luce che sconfigge e illumina le tenebre, quasi prefigurazione della luce del cero pasquale.
Ogni famiglia, per rendere onore al Santo, tagliava la legna e la custodiva in casa per realizzare la propria fanoja.
In tutti c’era il desiderio di realizzare il falò più grande e spettacolare e, per l’occasione, veniva organizzata una sorta di competizione tra quartieri per decretare la fanoja più bella.
Alla base delle fanoje venivano posti, in modo inclinato, fasci di legna secca e sottili, per procedere più agevolmente all’accensione. In cima, una croce o la foto del Santo a cui si aggiungeva un piccolo ramoscello d’ulivo, benedetto durante la domenica delle Palme dell’anno precedente. Dopo ore dall’accensione, quando il fuoco cominciava a scemare, gli adulti ponevano sotto la cenere le patate e arrostivano il pane e la carne. Bambini, adulti ed anziani consumavano tutto attorno al fuoco, cantando e ballando accompagnati dalle musiche storiche del paese.
L’accensione delle fanoje dunque, retaggio di una popolazione votata anticamente all’agricoltura, si inserisce profondamente nei solchi della nostra storia. Altre città della provincia di Foggia, in particolare Faeto, Casalvecchio e Serracapriola, continuano a portare avanti questa tradizione che, nonostante l’avvento della tecnologia, continua ad illuminare le ultime notti d’inverno e ad affascinare persone di ogni età.
Da altre categorie


Inaugurato a Casa Sollievo il nuovo sistema angiografico di ultima generazione
redazione - 6 Dicembre 2025
Medra Servizi & Urbano Chimica presentano il Calendario delle Botteghe 2026
redazione - 6 Dicembre 2025